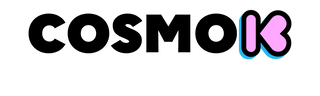”L’Ombra come inconscio e la luce nel processo creativo di individuazione”
“Non si raggiunge l’illuminazione immaginando figure di luce, ma portando alla coscienza l’oscurità interiore”
- Carl Jung -
Ne hanno parlato filosofi, è stata esplorata nell’arte figurativa e nella musica, in poesia, nel cinema, in fisica e astrofisica; l’oscurità è un tema complesso che racchiude un fascino innegabile. Ci si addentra nell’ignoto con trepidante timore alla scoperta della notte buia dell’anima, Jung direbbe alla scoperta dell’ombra.
La psicologia analitica di Carl Jung ha, infatti, tentato di spiegare l’oscurità della psiche definendola attraverso l’archetipo dell’Ombra.
L’Ombra, la parte più oscura dell’essere umano, quel lato nascosto che rappresenta i contenuti psichici rimossi, non elaborati e non in relazione o, parzialmente, con la parte cosciente. Una dimensione primitiva della nostra psiche, da cui hanno origine gli istinti repressi.

In letteratura, nel racconto di Stevenson, l’ombra dello stimato Dr. Jekyll è stata perfettamente incarnata dalla sua controparte Mr. Hyde, il lato non riconosciuto ed inconscio, che non integrandosi, finisce per prendere il sopravvento ed agire in modo distruttivo. Come il Dr. Jekyll, secondo Jung, gli esseri umani hanno una parte oscura che non sempre è visibile, poiché alla presenza della troppa luce essa sparisce e viene proiettata sull’Altro da noi.
La maschera di desiderabilità sociale che viene indossata e con la quale ci si identifica, cela quelle parti ritenute inaccettabili, parti non accolte e, tuttavia, ben riconosciute negli altri, siano esse tendenze immorali o anche solo fragilità umana. I tratti non ritenuti degni di descriverci e di presentarci al mondo vengono rigettati, disconosciuti, tanto da non essere più sotto il controllo cosciente. Per evitare che l’oscurità pervada l’essere, occorre contrastarla e ciò è possibile tramite la consapevolezza. Rimuovere, schiacciare, separare la propria parte Ombra significa farsi travolgere senza possibilità di trasformazione. Jung afferma: «La figura dell'Ombra personifica tutto ciò che il soggetto non riconosce e che pur tuttavia, in maniera diretta o indiretta, instancabilmente lo perseguita: per esempio tratti del carattere poco apprezzabili o altre tendenze incompatibili».
L'Ombra è l'ignoto, l’indesiderabile, ciò che dalla società viene considerato immorale, sconveniente, inadatto e di cui l’individuo opera un processo di rimozione, in quanto contenuto negato dall’io, relegandolo nella sua parte inconscia.
L'incontro con la propria parte Ombra risulta essere un arduo compito per l’io che, di fronte alla presunta minaccia dell’inconscio oppone resistenza.
Accanto alla paura degli elementi sconosciuti, potenzialmente evocati dall’inconscio, vi è la difficoltà di confrontarsi con le parti di sé inaccettabili, che negate e proiettate sull’Altro come forma difensiva, annientano l'angoscia dell'accesso di tali contenuti alla coscienza. Jung sostiene che «L'incontro con sé stessi è una delle esperienze più sgradevoli, alle quali si sfugge proiettando tutto ciò che è negativo sul mondo circostante. Chi è in condizione di vedere la propria Ombra e di sopportarne la conoscenza ha già assolto una piccola parte del compito.»

L'Ombra viene, dunque, secondo Jung, proiettata su di un individuo o su di un gruppo facendo sì che così siano gli altri ad incarnare le parti più oscure di sè, oppure, essa emerge nel sogno, tramite immagini quali Mefistofele, la Strega, il Briccone, il fauno ecc. Il problema del proiettare la propria parte oscura è che tale operazione non permette di riconoscersi autenticamente per ciò che si è. In situazioni patologiche dove avviene una totale scissione dell’Ombra, questa può prendere il sopravvento rendendo l’Io assoggettato ai propri voleri inconsci. La soluzione affinché ciò non avvenga è tramite la ricognizione e accoglimento dell’Ombra e, infine, con una sua integrazione e individuazione finale del soggetto.
L’integrazione di tale oscurità non elimina il negativo, ma consente la creazione di un processo creativo e trasformativo dell’individuo, che accogliendo sé stesso e conoscendo le proprie parti oscure, può tramutarle tramite consapevolezza, in fonte di luce.
L’Ombra, in quanto archetipo, riporta il significato ambivalente che c’è luce anche nel buio. Riconoscere gli aspetti ombrosi contribuisce alla percezione consapevole del processo trasformativo e fornisce potenzialità positiva poiché le parti non realizzate e schernite, se recuperate ed integrate, possono dare origine ad un Io più autentico.
L’Ombra è, dunque, un alleato a cui dare voce poiché grazie ad esso sarà possibile individuarsi, ovvero, effettuare quel processo di sviluppo psichico che costituisce la ricerca e realizzazione del proprio progetto esistenziale, rivelazione e accoglimento del proprio vero Sé.

L’uomo che si è confrontato con successo con la propria Ombra e l’ha integrata, si trasforma e si eleva, tuttavia, insorge un problema: «Egli si carica di conflitti nuovi, diviene un grave compito per sé stesso, perché non può più dire che gli altri fanno questo o quello, che essi sono in errore, che contro di loro bisogna lottare. Chi sia giunto a tanto vive nel raccoglimento interiore; sa che i difetti del mondo sono anche difetti suoi; e pur che impari a dominare la sua oscurità, ha fatto qualcosa di reale per il mondo. È riuscito a risolvere almeno una minima parte dei giganteschi problemi irrisolti dei nostri giorni».
Il compito di ciascuno è, in definitiva, quello di accettare la propria l’oscurità e integrarla nella personalità, renderla cosciente e lavorare su di essa. Trascurarla e permetterle di continuare a operare a livello inconscio può essere pericoloso e allontanare l’individuo dall’equilibrio. Il benessere psicologico dipende proprio dal dare luce alle zone d’ombra consapevoli del fatto che una volta riconosciuta la propria oscurità essa non potrà più essere indagata nell’Altro come forma di deresponsabilizzazione, ma che il carico del proprio funzionamento adattivo alla vita sarà sempre personale.
__________
Bibliografia:
Jung C.G. 1928, L’Io e l’inconscio, in Opere, vol. 7, Boringhieri, 2012.
Jung C.G. 1934/1954, Gli archetipi dell'inconscio collettivo, in Opere, vol.9/1, Boringhieri, 2008.
Jung C.G. 1938/1940, Psicologia e religione, in Opere volume 11, Boringhieri, 1979.